«Esso fu originario, e nato nella nobil terra di Tolmezzo capitale di tutta la Carnia nostra montuosa» (Liruti) da famiglia illustre, ricordata tra quelle nobili nel De antiquitatibus Carneae di Fabio Q. Ermacora, all’inizio del secolo, probabilmente nel 1500; nel 1552 era già da alcuni anni medico a Udine, stimato per la sua grande preparazione e competenza. Infatti, dopo aver svolto a Tolmezzo la sua professione, acquistò una tale stima e rinomanza che la città di Udine lo prescelse come suo medico con lauto stipendio. «Avrà egli appreso le prime lettere verisimilmente in Patria, ed assieme l’eloquenza nelle due dotte lingue greca, e latina, avendo sempre quella comunità, come gli altri luoghi di conto della Provincia, mantenuto a spese del pubblico un maestro di scuola pe’ suoi abitanti; e quindi bene istruito in queste passò alla Università di Padova, dove applicatosi alla filosofia, ed alla medicina teorica e pratica, e fatti di sé i soliti esperimenti, con lode, ed approvazione ottenne la laurea nella filosofia, e nell’arti, come si costuma» (Liruti). L’Università di Padova era un centro di attrazione per la formazione sia in campo giuridico sia in quello medico oltre che, naturalmente, nel settore umanistico; qui si affermava il culto della oggettività nella scienza della “fabrica” dell’uomo, ossia nell’anatomia, nella botanica, quella farmaceutica in specie, e nell’insegnamento clinico svolto direttamente al letto del malato. Era importante soprattutto l’orientamento metodologico, che avrebbe caratterizzato i laureati di quello studio: descrizione, dimostrazione, studio sistematico; la frequente tendenza alla pubblicazione di resoconti di ciò che si era osservato; ovviamente, una solida cultura medica ed anatomica. ... leggi Formatosi in quell’ambiente il D. si distinse soprattutto per la sua competenza e umanità in occasione della epidemia petecchiale del 1552, che si sarebbe ripresentata anche nel 1560, e in altri due contagi di peste. Nel 1556 la pestilenza fu diffusa da forestieri, che pare fossero ebrei, con indumenti ammorbati provenienti da Capodistria. Nel 1572 quando il contagio, partito dal borgo di Gemona, sarebbe arrivato con lino ammorbato di Germania, il D., che aveva inventato contro la peste un farmaco complesso, costituito da ben 48 ingredienti, fu definito «il liberatore della città dopo Dio». Non si conosce la data della sua morte, avvenuta senz’altro dopo il 1576, anno di pubblicazione del suo Trattato della peste et delle petecchie, decesso, pare, a causa della peste, in quanto avrebbe rifiutato ogni assistenza, per non diffondere il contagio. Il morbo era talmente diffuso anche nei secoli precedenti che alla fine del 1445 il Maggior consiglio di Udine aveva stabilito di «fare un lazzaretto fuori di città per accettare li forestieri appestati e così quelli, che fossero scacciati dalla città per la peste». Era stata scelta a tale scopo una casa presso la chiesa di San Gottardo e per oltre due secoli essa venne adibita a luogo di isolamento dei sospetti di peste e organizzata secondo norme precise e razionali. Il Trattato della peste et delle petecchie, che rientra a pieno titolo nella letteratura di divulgazione scientifica, fu definito da Giuseppe Capodagli, «opera singolarissima, et utilissima alla conservazione della sanità, e più fiate isperimentata, e felicemente usata così nella stessa città di Udine, come in altri luoghi della Patria, e che perpetuerà gloriosamente il di lui nome». La pubblicazione dell’opera, 40 capitoletti per poco più di 150 pagine, fu molto contrastata, se leggiamo con attenzione quanto scrive, in apertura, «Ai molto magnifici et nobilissimi signori, i sette signori deputati della città di Udine, signori miei osservandissimi». Come Prometeo, modellati gli uomini di “loto” ricorse a Minerva, dea della sapienza, perché desse loro anima e vita, così lui, composta un’opera «quasi di polvere, e fango» chiede ad essi che le diano «vigore, et spirito [e] contra le lingue de maldicenti adoperino parte di quella loro autorità»; e prosegue: «Perché nel vero io conosco esserci il costume d’alcuni c’hanno l’intelletto poco sano, et gli occhi offuscati in modo che difficilmente possono per natura loro, né vedere, né dire delle cose che sono da molti giudicate buone, e lodevoli, altro che male. Il che molto forse più facilmente s’indurranno à fare contra di me»; e ancora accenna ai «latrati de maligni» e ai «morsi dei maligni». Probabilmente la corporazione scientifica non accettava che un carnico “homo novus” pubblicasse un’opera senza la sua approvazione e soprattutto in lingua volgare italiana e non in latino. Contro costoro D. affermò che egli la dava alle stampe «per brama di giovar à molti [benché] sappia l’huomo essere di natura fragile, e caduca si fattamente, che non trovi rimedio alcuno contra la morte […] nondimeno con la cura, e buon governo suo, e de Medici intendenti può ben reggere, e sostentare in vita se stesso; e schernendosi da gli artigli della morte empia, e violenta, tanto oltre condurre gli anni suoi, quanto le forze ne l’huomo infuse, e regolate dal divin consiglio nel comportano»; questo intento lui lo ha dimostrato «per prova» e spera di «riportarne da tutti i buoni, che lo leggeranno, se non honore, et gloria di scienza, et di virtù, almeno nome di grato servitore, et amorevole Cittadino». Di seguito vengono pubblicate le Lettere patenti dell’officio della sanità della magnifica città di Udine con sigillo e firma di Giovanni Domenico Salomoni, “cancellarius” mandato, in cui si afferma che «de la lode, ch’è il vero premio de le virtuose operazioni, non si debbono in alcuna parte defraudar quelli, i quali con lo valore, e dottrina loro hanno al mondo molti beneficii arrecato […] quelle [azioni] sono massimamente degne di commendatione, che all’utile, et conservatione della vita dell’huomo sono rivolte» e si attesta che il D. «ha nel vero con fedeltà, et amorevolezza grande assiduamente atteso all’officio nostro». Nella prefazione dell’autore ai lettori egli scrive che «essendosi già alquanti anni, o per superiori operazioni de corpi celesti, e maligni influssi, o per nostre scelleratezze, e inique opere da giusta ira di Dio à nostra correzione nelle parti circonvicine appicciata la mortifera pestilenza», ha deciso di pubblicare il trattato dove si vedrà che: «qui abbia raccolto non vanamente tutti i singolari, e salutari rimedii, che gli antichi, e moderni scrittori hanno in tal materia raccomandati a gli scritti suoi, e parimente altri rimedii approvati, e sperimentati». Sottolinea infine che: «ho voluto pubblicarla in lingua volgare italiana, acciò che da tutti sia intesa, come cosa, ch’a tutti generalmente habbia d’esser di non poco giovamento, e salute […] [accettatela] non mordendola, ma da i morsi de maligni pietosamente difendendola, e guardandola; che sarà opera giusta, et cortese, e degna di voi», ricordando un po’ l’affermazione di Machiavelli «sendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende», e «a conservation della nostra sanità, senza la quale questa vita, che per altro è così dolce, et cara, si rende sopra ogn’altra cosa grave, e noiosa». Interviene anche lo stampatore che invita i lettori a leggerla «senza quell’affetto, che suol alcuna volta indur qualch’uno a lacerar ingiustamente l’altrui fatiche […] senza l’invidia a canto». Ulteriore viatico è fornito da due sonetti in lode del D., uno di Giovanni Battista Bratteolo, l’altro di Gerolamo Giorgia, il quale afferma che le antiche e moderne scuole devono cedergli il passo. Nel primo capitolo G. D. rivela di aver bene fatto suo il metodo acquisito all’Università di Padova e la lezione degli antichi, come Platone del Timeo, i quali, trattando di qualche materia, avevano l’abitudine, «acciò che ella senza confusione alcuna potesse essere da tutti facilmente intesa» di incominciare «se era la cosa semplice dalla diffinitione di quella, e essendo equivoca dalla divisione, e così secondo la propria sostanza la diffinivano». Impostazione e metodologia che lui applicava analiticamente nel suo trattato. A questo punto si può facilmente comprendere chi fossero gli avversari e per quali motivi: quelli che legati al “principio d’autorità” rifiutavano l’insistenza del D. sulla “esperienza” (rimedi “sperimentati”), in genere persone chiuse, provinciali, ignare del dibattito sulla questione delle lingue, il quale da anni infervorava anche l’ambiente veneto, quello padovano in particolare.
ChiudiBibliografia
G. DACIANO, Trattato della peste et delle petecchie, Venezia, Zanetti, 1576.
CAPODAGLI, Udine illustrata, 399-400; Capitolo per la buona regola e governo del pubblico lazzaretto della Città d’Udine a S. Gottardo, Udine, Murero, 1713; LIRUTI, Notizie delle vite, IV, 353; G. B STRATICO - F. M. MARCOLINI, Delle principali fabbriche di Udine nel secolo XVI e di un’operetta del dott. Daciano, con qualche cenno sul tifo petecchiale del 1817, Venezia, Ricotti, 1817; G. AMASEO, Historia della crudel zobia grassa et altri nefarii excessi et orrende calamità intervenute in la città di Udine et Patria del Friuli del 1511, in F. BIANCO, La «crudel zobia grassa». Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra ’400 e ’500, Pordenone, Centro studi Menocchio/Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 1996.
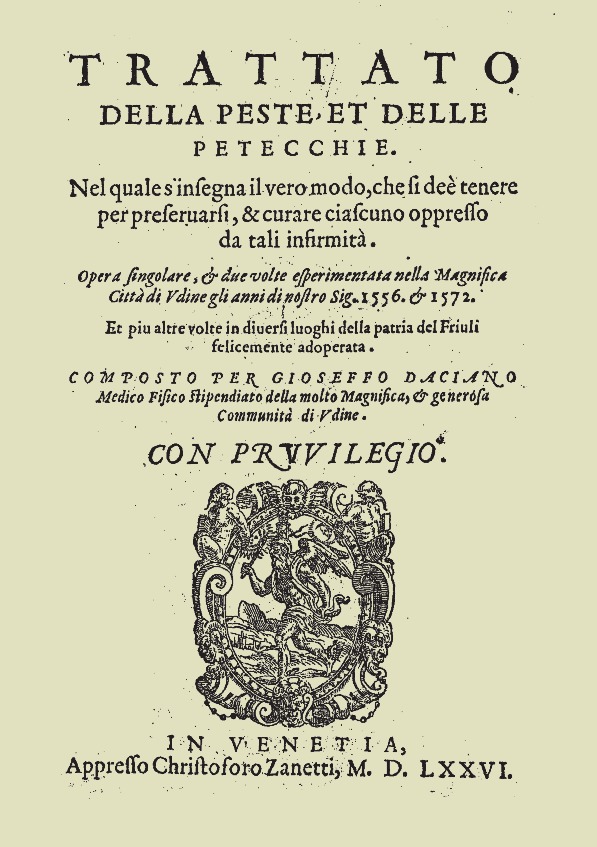
Nessun commento